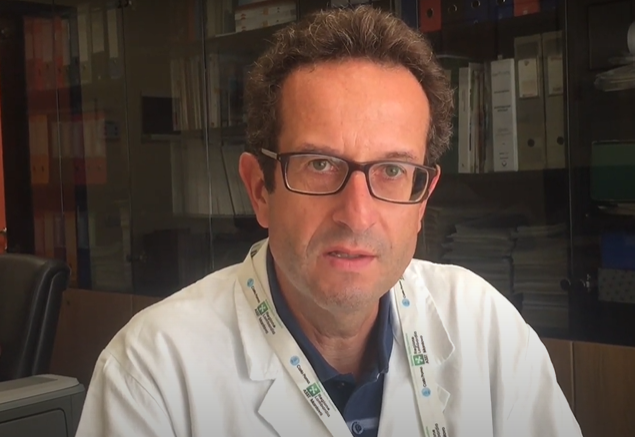MANTOVA – Il 2020 era un anno bisestile, e proprio il 29 febbraio arrivò la conferma del primo caso di Covid-19 nella provincia di Mantova. Si trattava di un uomo di 84 anni residente a Cogozzo di Viadana, un comune che sarebbe poi diventato uno dei più colpiti dalla prima, terribile ondata della pandemia.Tuttavia, già due giorni prima, all’ospedale Poma erano arrivati i primi pazienti positivi, trasferiti da strutture fuori provincia. A distanza di cinque anni esatti, abbiamo voluto ripercorrere quei giorni drammatici, che si trasformarono presto in settimane e mesi di lotta incessante, con uno dei medici che divenne un simbolo della battaglia contro il virus: il primario dell’Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Asst Mantova Massimo Franchini.
FEBBRAIO 2020: CI SI RESE SUBITO CONTO DELLA GRAVITA’ DELLA SITUAZIONE?
Nei giorni tra il 20 e il 27 febbraio 2020, dopo il primo caso registrato a Codogno, anche Mantova iniziò a contare i primi malati di Covid. In quei primi giorni, come medici, avevate già compreso l’entità della minaccia che incombeva sull’Italia?Purtroppo sì, e ce ne siamo resi conto molto rapidamente. La velocità con cui il virus si diffondeva ci fece capire subito che eravamo di fronte a una situazione gravissima, un vero e proprio tsunami sanitario. Il primo caso autoctono a Mantova è stato registrato più tardi rispetto ad altre zone critiche come Codogno, Piacenza, Cremona, Crema, Lodi e Bergamo. Questo ritardo ci ha dato un minimo margine di vantaggio, permettendoci di organizzarci meglio: l’unità di crisi dell’ospedale era già stata attivata e avevamo avuto il tempo di suddividere i reparti in aree Covid e non Covid. Anche se si trattava di pochi giorni di differenza, quel tempo extra è stato fondamentale per permettere al personale sanitario di adottare le prime contromisure e cercare di prevenire il collasso del sistema ospedaliero. In altre strutture, purtroppo, la situazione invece era già tragica con l’impossibilità di curare le persone che morivano in ambulanza o nei Pronto soccorso, perché non c’era più spazio per ricoverarle.
MARZO-APRILE 2020: L’OSPEDALE SOTTO ASSEDIO
Dopo i primi casi, arrivarono settimane di totale emergenza. Voi medici e gli altri operatori sanitari lavoravate senza sosta, eravate praticamente reclusi negli ospedali. Ci furono momenti in cui avete pensato di non farcela?
Il periodo tra marzo e fine aprile 2020 è stato davvero devastante. Ricordo quando appresi che duecento operatori sanitari del Poma avevano dovuto ricorrere all’assistenza psicologica. Anche io ne ebbi bisogno, perché ero completamente in burnout. In quella prima fase, insieme a Giuseppe (il dottor De Donno, allora primario della Pneumologia del Poma ndr) , iniziammo a sperimentare l’utilizzo del plasma iperimmune, e su alcuni pazienti riscontrammo risultati positivi.
 La notizia si diffuse rapidamente in tutta Italia, e da quel momento cominciarono ad arrivarci centinaia di telefonate al giorno da parte di colleghi che volevano informazioni sulla plasmoterapia. Era un flusso continuo, quasi impossibile da gestire. Mi trovai in una situazione di estrema difficoltà, in cui non riuscivo più a distinguere il giorno dalla notte. E posso solo immaginare quanto fosse ancora più dura per Giuseppe, che si trovava in prima linea, completamente immerso nella battaglia contro il virus.
La notizia si diffuse rapidamente in tutta Italia, e da quel momento cominciarono ad arrivarci centinaia di telefonate al giorno da parte di colleghi che volevano informazioni sulla plasmoterapia. Era un flusso continuo, quasi impossibile da gestire. Mi trovai in una situazione di estrema difficoltà, in cui non riuscivo più a distinguere il giorno dalla notte. E posso solo immaginare quanto fosse ancora più dura per Giuseppe, che si trovava in prima linea, completamente immerso nella battaglia contro il virus.
Nel frattempo, l’unità di crisi riorganizzò l’ospedale da cima a fondo. Inizialmente si tentò di dedicare alcuni letti ai pazienti Covid, ma ben presto ci si rese conto che non sarebbe bastato. La strategia si invertì: l’intero ospedale divenne Covid, mentre solo pochi letti furono riservati alle altre attività. Fu una trasformazione necessaria, ma che portò con sé problemi enormi.
L’ALTRA FACCIA DELLA PANDEMIA: LE CURE NEGATE PER ALTRE MALATTIE
Già, perchè lì si è innescato uno degli effetti collaterali più devastanti della pandemia, l’impossibilità di garantire cure adeguate a tutti quei pazienti che soffrivano di altre patologie.
È stato uno dei problemi più gravi. Molti pazienti non hanno avuto accesso alle cure necessarie. Penso, ad esempio, a chi ha avuto un infarto e non è stato trattato in modo tempestivo, oppure a chi soffriva di altre malattie gravi che non sono scomparse con il Covid, ma sono state trascurate. I numeri parlano chiaro: ai morti per il virus vanno aggiunti tutti coloro che hanno perso la vita a causa della mancata diagnosi o delle cure interrotte. Nel mio reparto, nel 2024, abbiamo osservato un preoccupante aumento delle malattie oncoematologiche. Analizzando i dati, abbiamo scoperto che non c’era stato un vero aumento dei casi, ma semplicemente negli anni tra il 2020 e il 2023 erano state fatte meno diagnosi. Questo significa che molte persone hanno scoperto la loro malattia troppo tardi, quando era ormai più difficile intervenire.
LA SPERIMENTAZIONE DEL PLASMA IPERIMMUNE: UNA SPERANZA SPEZZATA
Torniamo al 2020 e al primo periodo della pandemia quando lei e il dottor Giuseppe De Donno siete saliti alla ribalta delle cronache nazionali per il plasma iperimmune. Com’è nata la vostra sperimentazione?
È nata dalla disperazione. Abbiamo guardato alla letteratura scientifica. Un editoriale pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases suggeriva l’utilizzo del plasma iperimmune che da oltre un secolo si usava come terapia di prima linea per le epidemie.
Dalla Cina purtroppo le informazioni sul coronavirus arrivavano con il contagocce, per cui devo proprio dire che la disperazione ci ha fatto esplorare questa terapia. Giuseppe ci spronava continuamente perché in quel periodo, ripeto, non c’era nulla: non si utilizzavano ancora nemmeno il cortisone e l’eparina. L’unica terapia disponibile erano gli antivirali anti-HIV, che però furono rapidamente abbandonati perché causavano più danni che benefici.
In quei giorni drammatici  la fortuna è stata di aver avuto un medico, il dottor Stradoni, come direttore generale. Appena Giuseppe e io siamo andati a parlargli per proporgli questa strada, che era ovviamente tutta in salita in quanto si trattava di una terapia sperimentale, lui ci ha dato carta bianca e ci detto di andare avanti senza perdere ulteriore tempo. A Pavia intanto, il dottor Cesare Perotti era giunto alle nostre stesse conclusioni. Così, decidemmo di unire le forze potendo contare tra l’altro sulle alte professionalità del Policlinico. Questa nuova energia ci ha spinto ad andare avanti e di fatto il plasma iperimmune è rimasto l’unica terapia per un anno in quanto i monoclonali sono arrivati a marzo 2021 e i primi effetti dei vaccini si sono avuti tra marzo-aprile sempre del 2021. Prima di quel momento non c’erano terapie specifiche, si erano fatti dei tentativi usando farmaci vari come gli antinfiammatori per tentare di bloccare gli effetti del Covid. Ecco perché la terapia che arrivava da Mantova e Pavia ha fatto rapidamente il giro del mondo. Mi viene in mente ad esempio quando, a inizio aprile 2020, il dottor Perotti mi ha comunicato che aveva ricevuto una telefonata dagli Stati Uniti dal braccio destro del dottor Fauci che gli aveva chiesto se poteva avere in visione il protocollo italiano sul plasma. Glielo abbiamo girato, e il nostro protocolo è stato utilizzato negli Stati Uniti dove hanno trasfuso ben 500mila persone.
la fortuna è stata di aver avuto un medico, il dottor Stradoni, come direttore generale. Appena Giuseppe e io siamo andati a parlargli per proporgli questa strada, che era ovviamente tutta in salita in quanto si trattava di una terapia sperimentale, lui ci ha dato carta bianca e ci detto di andare avanti senza perdere ulteriore tempo. A Pavia intanto, il dottor Cesare Perotti era giunto alle nostre stesse conclusioni. Così, decidemmo di unire le forze potendo contare tra l’altro sulle alte professionalità del Policlinico. Questa nuova energia ci ha spinto ad andare avanti e di fatto il plasma iperimmune è rimasto l’unica terapia per un anno in quanto i monoclonali sono arrivati a marzo 2021 e i primi effetti dei vaccini si sono avuti tra marzo-aprile sempre del 2021. Prima di quel momento non c’erano terapie specifiche, si erano fatti dei tentativi usando farmaci vari come gli antinfiammatori per tentare di bloccare gli effetti del Covid. Ecco perché la terapia che arrivava da Mantova e Pavia ha fatto rapidamente il giro del mondo. Mi viene in mente ad esempio quando, a inizio aprile 2020, il dottor Perotti mi ha comunicato che aveva ricevuto una telefonata dagli Stati Uniti dal braccio destro del dottor Fauci che gli aveva chiesto se poteva avere in visione il protocollo italiano sul plasma. Glielo abbiamo girato, e il nostro protocolo è stato utilizzato negli Stati Uniti dove hanno trasfuso ben 500mila persone.
Perché allora questo contrasto al plasma iperimmune che abbiamo visto a livello nazionale?
In Italia si scelse la strada della prudenza, ma a un certo punto serviva un cambio di passo. Negli Stati Uniti il plasma è stato autorizzato in emergenza e ancora oggi può essere usato non più in emergenza come emocomponente. Qui da noi, invece, la burocrazia ne ha rallentato l’uso, riducendone drasticamente l’efficacia. Nel 2021, lo Studio Tsunami fu usato come pretesto per sconsigliare il plasma in tutta Italia. Ma fu una scelta miope: i monoclonali si rivelarono efficaci, ma il virus mutò rapidamente, rendendolo resistente a quest’ultimi. Il plasma, invece, sarebbe stato ancora un’arma preziosa, soprattutto per i pazienti immunodepressi: 3 milioni di persone nel nostro Paese che avrebbero sicuramente avuto più chance di guarire dalla malattia da Covid. Non voglio puntare il dito, ma spero che dagli errori del passato si impari per il futuro.
come emocomponente. Qui da noi, invece, la burocrazia ne ha rallentato l’uso, riducendone drasticamente l’efficacia. Nel 2021, lo Studio Tsunami fu usato come pretesto per sconsigliare il plasma in tutta Italia. Ma fu una scelta miope: i monoclonali si rivelarono efficaci, ma il virus mutò rapidamente, rendendolo resistente a quest’ultimi. Il plasma, invece, sarebbe stato ancora un’arma preziosa, soprattutto per i pazienti immunodepressi: 3 milioni di persone nel nostro Paese che avrebbero sicuramente avuto più chance di guarire dalla malattia da Covid. Non voglio puntare il dito, ma spero che dagli errori del passato si impari per il futuro.
E SE OGGI SI RIPRESENTASSE UN’EPIDEMIA?
A proposito di futuro, anzi di presente, saremmo pronti oggi per affrontare un’altra eventuale epidemia?
In parte sì. Abbiamo migliorato i sistemi di protezione e le strutture sanitarie. Ma la vera battaglia si vince sul territorio, curando i pazienti nelle fasi iniziali quando il virus non si è ancora replicato in modo importante, così da evitare i ricoveri. E su questo siamo ancora molto indietro.
Cosa ne pensa del piano pandemico del governo?
Innanzitutto vorrei ricordare che ci sono state tante polemiche sulla mancanza o inadeguatezza del piano pandemico precedente. Ma anche il migliore dei piani pandemici non avrebbe potuto prevedere quello che è successo. Dovremmo però prendere spunto dal passato per cercare di fare un piano pandemico efficace. Ho letto quello attuale che è concentrato prevalentemente sulla tracciabilità, sulla prevenzione, sull’uso delle mascherine che vanno bene come misure generali per ridurre la trasmissione dell’infezione. E’ un piano che non parla di terapia ed è logico perché per un eventuale nuovo virus ovviamente la terapia non c’è. Per un nuovo virus si devono sviluppare i farmaci. Ma teniamo conto che i farmaci e i vaccini hanno impiegato un anno per arrivare che è il tempo minimo necessario perché un farmaco possa essere messo in commercio. Invece il plasma può essere disponibile molto rapidamente. E questa sono convinto debba essere la prima terapia da utilizzare anche in future pandemie. Gli americani lo hanno capito perché, o si lasciano morire i pazienti senza terapia o si cerca di fare qualcosa con quanto si ha a disposizione.
E per quanto riguarda i vaccini? Cosa ne pensa di questo approccio dell’attuale governo che anche nel piano pandemico ha promosso i vaccini ma ha detto no alla restrizioni delle libertà personali se non in casi eccezionali?
I vaccini hanno salvato milioni di vite umane: 150 milioni è il dato stimato che ho letto in un recente articolo. Purtroppo ho avuto cari amici che sono morti perché non si sono voluti vaccinare. Ma credo che, anche per quanto riguarda i vaccini, dobbiamo prendere lezione da quanto accaduto. La loro obbligatorietà deve essere decisa rapidamente ma altrettanto rapidamente deve essere tolta quando non è più necessaria. E’ lo stesso per i lockdown e per altre misure impopolari che vanno prese velocemente in caso di diffusione di un virus ma allo stesso modo vanno rimosse al più presto quando non sono più necessarie.
IL RICORDO DI GIUSEPPE DE DONNO
Lei anche in questa intervista ha citato tante volte il dottor Giuseppe De Donno. Cosa si porterà dentro di lui?
Io non sono più stato lo stesso dopo il Covid ma soprattutto non sono più stato lo stesso dopo la morte di Giuseppe: avrei avuto ancora tante cose da dirgli, tante questioni su cui confrontarmi. Nell’estate del 2021 ci frequentavamo poco perché lui aveva lasciato l’ospedale per diventare medico di medicina generale. Avrei voluto incontrarlo, parlare con lui anche del suo malessere, cercare di aiutarlo in qualche modo, come un po’ avrebbero voluto fare tutti gli amici della sua cerchia.
Ho dedicato, come ho potuto, i cinque anni professionali della mia vita successivi al Covid, per cercare di trovare la verità sulla sull’utilizzo del plasma. Era importante farlo: lo dovevo sia a tutti i pazienti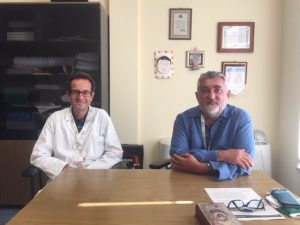 che abbiamo curato ma soprattutto alla memoria di Giuseppe.
che abbiamo curato ma soprattutto alla memoria di Giuseppe.
Ho trovato tanti ostacoli nelle iniziative che faccio per ricordarlo, anche per divulgare il libro che ho scritto (Gialloplasma: una storia di coraggio e speranza ai tempi del Covid ndr). In tanti, anche tra i miei vertici ospedalieri, mi hanno detto “ma lascia stare De Donno, lascialo riposare in pace”. Sono d’accordo che sia giusto lasciarlo riposare ma questo non deve voler dire dimenticarlo. Dobbiamo rendere giustizia a quello che ha fatto perché lui è un eroe del Covid e ha dato la vita per il Covid. E’ vero che Giuseppe aveva una sua fragilità personale, ma sono sicuro che se non ci fosse stata la pandemia lui sarebbe ancora con noi. Il Covid infatti ha aggiunto alla sua situazione una grande stanchezza e un malessere profondo per non aver potuto curare tutte le persone che si erano ammalate. E a tutto ciò si sono aggiunte le polemiche che per lui sono state un carico emotivamente troppo pesante da sopportare.